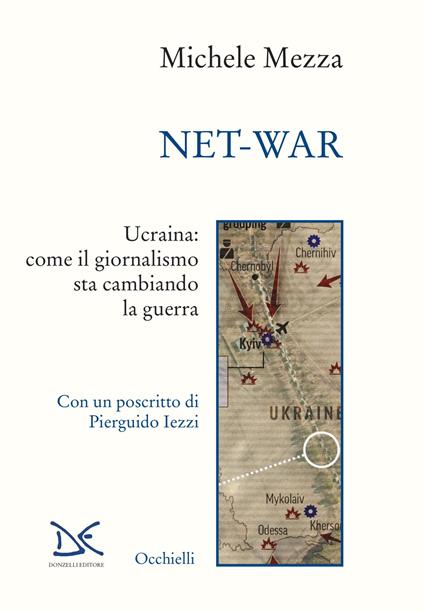Net war, il presente dei giornalisti e del suo sindacato. Una riflessione sul libro di Michele Mezza
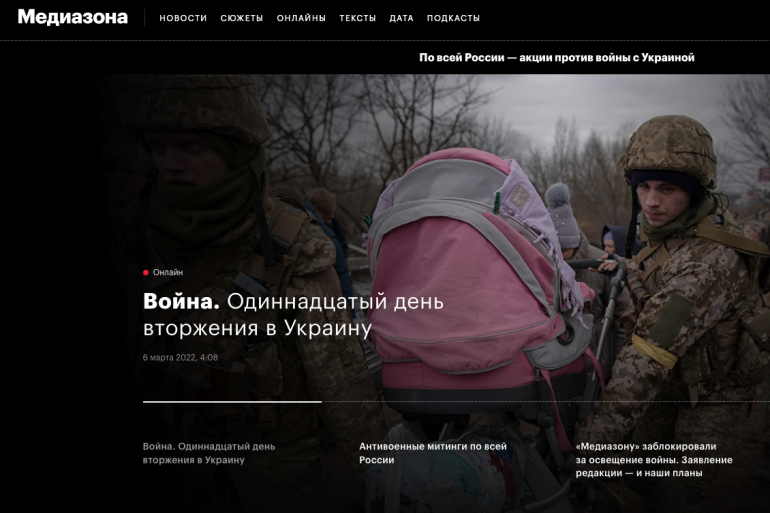
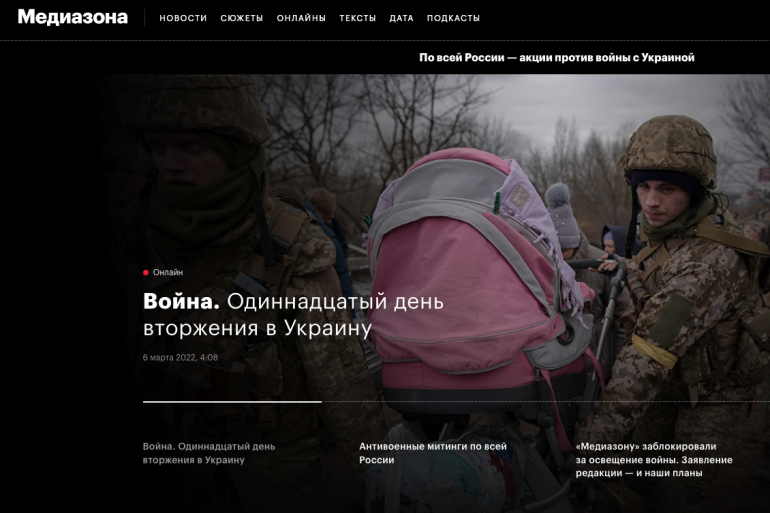
di Lazzaro Pappagallo – Segretario Associazione Stampa Romana
La guerra in Ucraina e il suo carico di morte e distruzione innescato dall’aggressione russa.
La guerra che si combatte corpo a corpo nelle città, nei villaggi, nelle foreste e negli anfratti del nord e sud est del paese che Putin vorrebbe cancellare dalla Storia, un errore di Lenin, ma che resiste e che crea un grande punto di domanda all’Europa nella gestione delle conseguenze economiche e nella spinta sulla pace per evitare il rischio nucleare.
Una guerra totalmente nuova perché nel tempo della mediamorfosi come ricorda Michele Mezza nel suo libro Net war è una guerra simulcast, vista e osservata dal basso e dall’alto.
Dal basso con la georeferenziazione dei cellulari e con il ruolo attivo civico delle reti sociali.
Dall’alto con la flotta dei satelliti di Elon Musk. E anche questa è una prima volta. Un privato, un grandissimo capitalista che entra nel gioco della guerra tra Stati con i suoi occhi celesti.
All’interno di queste coordinate ci siamo noi e Michele Mezza fa alcune osservazioni specifiche su come stia cambiando e come sia già cambiata la nostra professione e come di fatto converga sia sugli strumenti usati per la guerra (cellulari e reti sociali) sia nel determinarsi in funzione della sicurezza digitale di un apparato statale. La incapacità di comprendere questi cambiamenti, ad avviso di Michele, nostro stimato collega di riflessioni comuni sul destino della nostra categoria, anchilosa il sindacato italiano bloccandolo in una estenuata paralisi.
E qui arrivano le personali valutazioni di chi ha avuto l’onere e l’onore di guidare una cellula territoriale di una certa importanza nel nostro piccolo mondo.
Sotto la mia guida proprio perché ho visto la stalla aperta e i buoi già in fuga abbiamo cercato di proporre in Stampa Romana qualcosa di diverso facendo della formazione digitale una leva sia del riconoscimento di quanto stava accadendo dentro e fuori le redazioni (Jill Abramson docet) sia del recupero di forme di conoscenza non consone alla tradizione cassetta degli attrezzi.
Questo ci ha consentito una discreta dose di eresia sindacale, apprezzata o contestata a seconda dei casi ma necessaria per posizionarsi sulla rotta giusta che è quella indicata da Michele nel libro, una possibilità mai vista di essere prosumers produttori e consumatori di contenuti anche giornalistici da parte dei cittadini.
È sufficiente?
La risposta è negativa e concordo con la critica di Michele.
Il passo successivo non può che essere per noi, dopo averne tracciato la strada, accogliere quelle figure professionali che fanno da cerniera e da architravi del giornalismo digitale. E accoglierli per un sindacalista significa aprire le porte di Stampa Romana alla loro iscrizione. Sarà una delle ragioni alte del prossimo congresso; una sfida inedita che abbiamo voglia di giocare non trascurando mai le ragioni altre, quelle di chi invece vorrebbe tenere fermo il nostro mondo alle coordinate del ventesimo secolo.
Non mi ritrovo invece nell’equazione secondo la quale – taglio con l’accetta -i giornalisti siano funzioni non tanto della logistica militare in zona di guerra quanto della sicurezza di uno stato, nel nostro caso occidentale e quindi il ruolo recente scoperto dal Copasir nel controllare alcuni profili professionali di colleghi.
Se è vero che dovremmo tutti essere vigili sul cloud nazionale su chi se lo aggiudica, sulla sovranità (termine che torna di moda) digitale del nostro paese la sovrapposizione cybersicurezza nazionale giornalismo mi crea problemi.
Uno è proprio extra ragionamento. Da vecchio ormai obiettore di coscienza e ancora convinto pacifista non digerisco una colleganza giornalismo apparato militare.
Ma questo è istinto che non ha nulla a che fare con il ragionamento e che mi verrebbe rinfacciato visto che la stessa creazione di Internet arriva da massicci investimenti pubblici della difesa americana.
L’altra questione, un po’ più ragionata, invece arriva proprio dalla vicenda di Julian Assange ricordata giustamente da Mezza in coda a Net war.
Se assumiamo il punto di vista del giornalismo come un pezzo della cybersecurity allora potrebbero avere ragione gli Stati Uniti ad accusare di spionaggio Assange e a condannarlo a 175 anni di carcere per aver violato carte in cui erano evidenti i crimini di guerra compiuti in Iraq.
La stagione del Watergate e del primo emendamento, la stagione del Vietnam è stata sepolta dai morti delle Twin Towers. E le democrazie avanzate in questo, nella tutela dell’interesse nazionale, non si stanno mostrando molto diverse dalle autocrazie orientali. Se i giornalisti che sono e restano un cane da guardia si “arruolano“ anche per ragioni oggettive di mezzi digitali il rischio è che finisca in gabbia non solo Assange ma anche un pezzo della nostra libertà professionale e della libertà democratica di una comunità.
IL LIBRO DI MICHELE MEZZA